Festival delle Terre (di festival – 2)
![]() Sono stato ieri all’inaugurazione del Festival delle Terre, a Villa Muscas. Il tema di quest’anno è Chi decide cosa c’è nel tuo piatto?, anche se la selezione dei cortometraggi mi pare comprenda titoli che hanno sempre a che fare in qualche modo con la sostenibilità ma esplorano il tema in maniera molto varia, fino all’essere, apparentemente… fuori tema.
Sono stato ieri all’inaugurazione del Festival delle Terre, a Villa Muscas. Il tema di quest’anno è Chi decide cosa c’è nel tuo piatto?, anche se la selezione dei cortometraggi mi pare comprenda titoli che hanno sempre a che fare in qualche modo con la sostenibilità ma esplorano il tema in maniera molto varia, fino all’essere, apparentemente… fuori tema.
Le solite domande, una constatazione e un avviso
Arrivo e, come per Leggendo metropolitano, mi chiedo che “giro” sia il Festival delle terre, e quanto costi. Per quanto riguarda le reti la brochure indica come sponsor il negozio di Eticando, fra gli altri, e fra i media partner c’è Lollove, Marrai a Fura e Scirarindi. Diciamo che mi sento più a casa, sensazione rafforzata dal fatto che vedo e saluto un buon numero di conoscenti, compresi due dei miei consiglieri comunali preferiti (si, gli stessi di cui ho segnalato a suo tempo i blog personali).
Sui costi non mi esprimo, però mi pare che la messa in opera non sia sfarzosa come l’altra (poi insomma non si può mai dire, ma a occhio è così; come ho detto l’altra volta un bilancio sociale esplicito di queste manifestazioni sarebbe una rivoluzione politica e culturale). Rispetto a questa apparente sproporzione di mezzi risalta ancora di più il successo, perché Villa Muscas è gremita, non si trova una sedia manco a pagarla.
Eppure, come constatiamo con Carlotta Comparetti di Lollove, non è che del Festival delle terre si sia parlato molto: e un po’ è questo il limite ancora una volta delle reti in Sardegna, che di te parlano i tuoi partner, però non entri nei discorsi comuni di tutti gli altri. Un problema ricorrente, c’entrerà forse il fatto che tutti gli studi dicono che in Sardegna prevale il capitale sociale di tipo esclusivo, fino al familismo amorale.
In realtà ho continui motivi di distrazione da riflessioni così elevate, e non dipendono da quel che passa sullo schermo. L’ultima volta che sono venuto a Villa Muscas, per la rassegna cinematografica normale, l’età media era sui settant’anni e il pubblico era all’apparenza composto di professoresse di lettere in pensione. Questa volta io e Valentina Scarpa del gruppo di Banca Etica notiamo subito entrambi, per motivi immagino diversi, che l’età media è molto cambiata e che più che anziane professoresse sono presenti avvenenti giovani signore e signorine in gran numero, talune anche impegnate in interessanti defilè. Si vede che il fior fiore delle giovinette cagliaritane ha un cuore sostenibile, evidentemente.
Chiudo questa breve presentazione generale, prima di passare al mediometraggio che ho visto, segnalando che all’interno è previsto un punto ristoro con dell’ottimo cous cous e nientemeno che una mescita del Birrificio di Cagliari: quindi se andate al Festival (dura fino a domenica) arrivate digiuni e consumate lì, che immagino serva anche a autofinanziare l’evento: non fate come me che mi sono presentato col panino del kebab di via Dante (peraltro uno dei migliori di Cagliari, va detto) e addirittura la birretta Ichnusa, che vergogna.
Cattedrali di sabbia (Paolo Carboni, Italia 2012)
Non so quanti di quelli che leggono il blog, soprattutto fra gli amici continentali, conoscano la storia della industrializzazione della Sardegna.
In due parole la storia è questa: fino agli anni ’50 la Sardegna, avvicinandosi in questo al meridione d’Italia, è una regione fondamentalmente agricola: gli insediamenti industriali – con l’importante eccezione delle miniere – sono per lo più legati al soddisfacimento di domande locali per l’edilizia, l’agricoltura, i servizi, la trasformazione di prodotti del settore primario, e sono quasi sempre di modesta entità. Industria “pesante” non ce n’è.
Negli anni ’50 e ’60 si progetta l’industralizzazione della Sardegna, secondo le idee di sviluppo allora in voga. E si scommette su quella che sembra l’industria del futuro: la chimica. Passano pochissimi anni e lo shock petrolifero del 1974 – con quello successivo del 1979 – segna la fine della scommessa. Da allora a oggi è una lenta agonia, peggiorata dal contemporaneo declino – e poi chiusura totale – delle miniere. Tutta la vicenda dura quindi appena trent’anni, al massimo quaranta: vuol dire che c’è una generazione di sardi, principalmente maschi, che ha conosciuto in gioventù l’esperienza di lasciare i campi o i pascoli o le barche e, alla vecchiaia, nell’arco della stessa vita, vive l’esperienza di tornare al punto di partenza, tentando di ricostruire per sé e per i propri figli un nuovo futuro in quegli stessi campi o pascoli o specchi d’acqua, con la differenza che quelli sono rimasti abbandonati per tutto questo tempo (e adesso sono anche inquinati, spesso). Ed è una generazione, oltretutto, che in buona parte della sua vita lavorativa non ha nemmeno lavorato in fabbrica, ma è stata in cassa integrazione, ha vissuto la trafila dei corsi di riqualificazione, dei lavori socialmente utili e così via. Verrebbe da parlarne come di una generazione perduta o più probabilmente di una specie di aborto evolutivo: un ramo della società sarda che si è orientato male e da cui pare che non possa germogliare niente. Raccontato così, mi rendo conto, è un disastro sociale: nella percezione collettiva dei sardi è, credo, una vicenda ancora non risolta, non valutata, anche perché non è passata del tutto, perché qualche azienda ancora si dibatte ed è difficile ragionare con freddezza o trovare il necessario distacco quando gli operai della Legler o della Vinyls sono lì che non sanno dove sbattere la testa.
Il documentario di Carboni scava in questa materia dando la voce dal basso ai protagonisti, e solo a loro: non parla mai un politico, un sindacalista, un economista, un giornalista. Sempre e solo operai – normalmente, in realtà, ex operai – i quali raccontano le loro storie.
Sfilano così quelli che da Portovesme si sono reinventati tonnarotti, quelli che sono ridiventati pastori, il perito chimico che ha aperto un birrificio, quello che si è messo le serre, gente che è tornata alle lampare, e così via. E insieme quelli che ormai hanno fatto in tempo a essere pensionati e riflettono su quel che è stata “la fabbrica” quando erano giovani e come gli ha cambiato a vita e gli ha insegnato un modello che già per i loro figli non ha più senso. E infine quelli che sono ancora prigionieri di casse integrazioni e contratti di solidarietà mentre la loro azienda passa da un’agonia all’altra. Sono tutti gente che staresti ad ascoltare per ore per il timbro di verità che ha quel che dicono, diversi sono molto profondi, quasi tutti lucidissimi.
Ecco, quel che colpisce è la lucidità: non tanto sul modello di sviluppo o sulle scelte macroeconomiche, ma su due altri temi. Intendiamoci: sono temi secondari, quello principale è il racconto del sogno industriale svanito – o della bolla che si è dissolta – attraverso le storie degli operai, ma io spettatore ho notato due cose.
La prima è il giudizio, ricorrente, preciso e tagliente, sull’inadeguatezza della classe politica sarda: non quella che decise l’avventura della chimica, ma quella che non ha saputo gestire la crisi. E soprattutto sui padroni, che vengono dipinti sostanzialmente come una banda di ladri, attraverso il meccanismo perverso dei contributi e degli aiuti di Stato. Altro che bardane: prendere i soldi, aprire una fabbrica in Sardegna, prendere altri contributi per far fronte alla crisi, aggravare la crsi per prendere altri contributi e alla fine intascare il tutto e andare via, lasciando macerie dietro di sé. Pinta sa linna e portala in Sardinna. Questa è la storia ricorrente che viene raccontata: una storia di rapina e di truffe.
Parentesi (visto che il tema è attuale): è anche una storia coloniale? Beh, certo nessuno di questo tipo di “imprenditori” citati è locale. Ma il tema spinoso sollevato è quello dei controlli: e se si può ragionare che a livello centrale potesse andar bene questo sperpero di denaro pubblico perché favoriva élite italiane legate al potere politico, la domanda rimane anche per i sardi: se l’ultimo operaio aveva capito benisismo il meccanismo, come hanno fatto a non capirlo (quasi) tutti coloro che hanno occupato posizioni di responsabilità economica e politica nell’isola? Chi ha mangiato a certe greppie era un collaborazionista che aderiva a modelli coloniali? Ho qualche dubbio sul fatto che una risposta del genere sia un po’ troppo autoassolutoria, e nelle pieghe delle storie raccontate dagli operai di Cattedrali di sabbia emergono risposte meno rassicuranti.
L’altro tema secondario ricorrente è quello della sottovalutazione dell’impatto ambientale delle industrie installate. Rapportato all’epoca, non è sorprendente: in fondo vale per il nucleare in altre parti del mondo. Ma è sull’oggi che i racconti assumono un sapore sinistro: perché in quelli che quelli che raccontano la fabbrica non ha fatto in tempo a atrofizzare la capacità di controllo e conoscenza del territorio così tipiche della civiltà contadina, e sanno benissimo che il tal pozzo, il tale terreno, la tale zona, il tale stagno sono inquinati, hanno ricevuto discariche pericolose se pure non si vedono. Bombe chimiche pronte ad esplodere, e non parliamo dei fanghi rossi di Portovesme, il cui racconto fa veramente paura. Anche qui sembra all’opera in Sardegna, per contrasto, una specie di rimozione collettiva: perché se sanno le cose con questa precisione questi operai, dovrebbero saperle anche gli amministraotri e coloro che sono deputati a vegliare sulla salute e la sicurezza dei cittadini. O no?
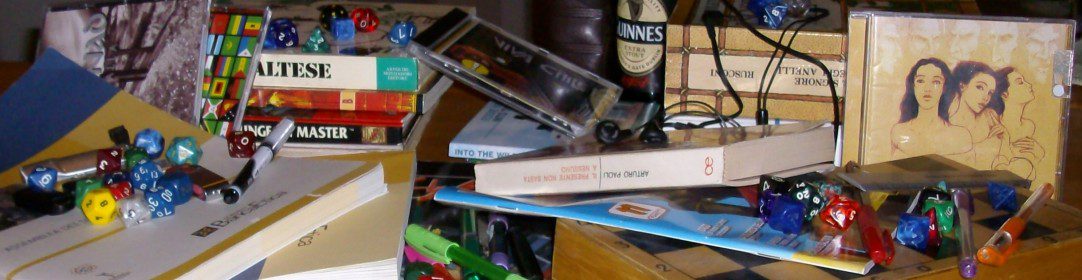




a me hanno impressionato molto il documentario “Terra nera” (http://stanlec.blogspot.it/2013/07/leni-e-linferno.html) e il secondo giorno il documentario sulla diga in Colombia
Il primo giorno non sono rimasto per la seconda proiezione, e il secondo giorno ero fuori. Tu hai visto tutto? Voglio dire, secondo te questi due sono i più interessanti del festival?
il terzo giorno non c’ero, nel secondo mi viene in mente un (piccolo) documentario sul land grabbing per fare centrali di energie alternative, rubando terreni fertili, per fare energie che non serve, solo per una (finta) legislazione “verde”, si fanno investimenti solo per i tropo generosi incentivi che poi paghiamo in bolletta, e in più Enel ed Eni sono gestite da banditi, andrebbero (ri)nazionalizzate, altro che.
ciao f.
Pingback: Ehi, ma guarda chi c’è!
Pingback: Il vostro inviato quasi in diretta dal “Festival delle terre” | La casa di Roberto