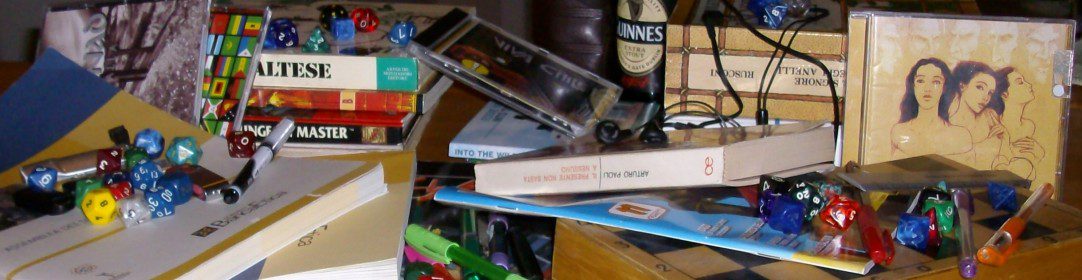Come gestire la sconfitta
Quella che trovate qui sotto è la traduzione dell’articolo di Tim Harford al quale ho accennato quando ho presentato la storia sorprendente di Gerald Ratner; parla di fallimenti e ripartenze, di correzioni in corsa e di vicende che invece sono finite su un bonario morto e di come cavarsela in questi casi.
L’articolo originale è stato pubblicato sulla rubrica che Harford teneva per il Financial Times ormai diversi anni fa, nel 2011, ma mi sembra sempre interessante. L’ho tradotto integralmente, comprese alcune brevi interviste finali a cura di una collaboratrice, Emma Jacobs, utili a mo’ di integrazione del testo principale. Nello stesso 2011 Harford ha pubblicato Adapt, why success always start with failure («Adattarsi: perché il successo inizia sempre col fallimento»), che non mi risulta però edito in Italia.
A proposito di libri editi o meno in Italia: l’articolo cita un certo numero di libri: laddove non mi risulta una versione italiana ho mantenuto il titolo in inglese, senza tradurlo, e ho messo il link.
Il titolo fa riferimento a un verso della (famosissima) canzone My way: ne ho inserito diverse versioni come colonna sonora dell’articolo, a partire dalla versione originale di Frank Sinatra.
Rimpianti? Ne ho qualcuno
di Tim Harford e Emma Jacobs
Una sera di giugno dell’estate del 2002, lo Shubert Theatre di Chicago presentò al pubblico un nuovo spettacolo musicale/balletto, Movin’ out. Lo spettacolo nasceva da una improbabile collaborazione fra Twyla Tharp, una coreografa dinamica e intraprendente, e il cantautore Billy Joel. Era in programma che debuttasse a Broadway l’ottobre seguente, ma i critici lo odiarono, proponendo recensioni che variavano dal «incredibilmente stereotipato e ingenuo in maniera imbarazzante» a «insistentemente ottuso e mal concepito»
Le critiche erano così esuberanti che il giornale di New York Newsday ruppe con la tradizione e pubblicò una delle recensioni più succulente molto in anticipo rispetto al debutto a Broadway. Toccò a Twyla Tharp, che aveva immaginato il progetto e firmato la direzione e la coreografia, mettere in qualche modo a posto il pasticcio multimilionario
L’esperienza di Tharp, raccontata nel suo libro The creative habit, è esemplificativa della risposta da manuale al fallimento: prese atto delle critiche, apportò i cambiamenti necessari allo spettacolo e debuttò a Broadway con recensioni entusiastiche. Lo spettacolo vinse due premi Tony, uno per le coreografie di Tharp.
La storia di Movin’ out colpisce non solo perché offre una storia incoraggiante di avversità e trionfo, ma perché questo genere di trasformazioni è inusuale. L’idea che uno dovrebbe riprendersi con più forza dai fallimenti è molto antica. La guerra alla fine vittoriosa di Re Robert Bruce contro gli inglesi si dice sia stata ispirata da un tenace ragnetto che tesseva la sua tela nella caverna dove lui si era rifugiato. Questo avveniva otto secoli fa, eppure improvvisamente questa idea sembra di moda – forse perché in questi giorni ci sono in giro un sacco di fallimenti.
In senso astratto, imparare dai propri errori è un’idea ovvia e priva di obiezioni. Nella pratica il concetto, così semplice e banale, è ricolmo di difficoltà. Chi può dire che sia stato commesso davvero un errore? E le lezioni da apprendere sono poi davvero così ovvie?
Abbiamo avvicinato alcune figure pubbliche – intrattenitori, artisti, politici e, ovviamente, banchieri – associati a fallimenti spettacolari di un tipo o dell’altro – e gli abbiamo chiesto che effetti il fallimento avesse avuto su di loro. Ci sono stati pochi che abbiano accettato e uno dei rifiuti – dall’ex responsabile operativo principale di una banca fallita – è stato particolarmente pittoresco. A quanto pare quelle storie di redenzione sul genere “imparare dai propri errori” sono meno affascinanti dal lato sbagliato della ruota della fortuna.
. . .
Mettetevi nei panni di Gerald Ratner. Due battute di cattivo gusto a proposito del suo impero di gioielliere e quello era svanito. Ratner dice di non avere imparato niente da questo. A prima vista questo sembra pazzesco, ma a pensarci bene è difficile capire cosa ci si potrebbe aspettare che avesse imparato, a parte il semplice fatto che non si devono denigrare i propri prodotti in pubblico. Il suo, più modesto, successo seguente con una catena di palestre non dimostra le lezioni che ha appreso, ma testimonia delle sue abilità di imprenditore, e quelle c’erano sempre state.
Twyla Tharp ha imparato di più dal suo fallimento in parte perché operava all’interno di un contesto progettato per permettere un processo di apprendimento. Il periodo di prova lontano dai palcoscenici principali è una istituzione teatrale ben consolidata, e c’è una onorevole tradizione di riscritture nei musical (A funny thing happened on the way to the forum [un musical di grande successo ispirato allo Pseudolus di Plauto, NdRufus] fu dapprima messo in scena, senza successo, senza il suo primo numero, Comedy tonight). Tharp concepì una trasformazione più profonda e di successo del suo lavoro di quanto sia abituale, ma si tratta di una differenza di grado piuttosto che di una differenza di genere.
I prototipi – la tournée in provincia; i focus group; l’edizione beta – sono un attrezzo di lavoro essenziale. Ma non avrebbero salvato l’impero di Gerald Ratner, e ci sono molte situazioni nelle quali prototipare semplicemente non è utile. Quale esattamente sarebbe il modo corretto di verificare il sistema di sicurezza di un impianto nucleare, per esempio? O, tanto per dire, un credit default swap su un pacchetto di mutui subprime? (in effetti gli impianti nucleari per addestrare i loro operatori fanno uso estensivo di simulatori – una buona idea, ma solo tanto buona quanto il simulatore stesso).
Un principio importante di sicurezza ingegneristica, che ora si sta facendo largo nei regolamenti bancari, è quello di disconnettere un sistema complesso in modo che piccole parti possano collassare senza compromettere il tutto. Questo è saggio ma non è sempre facile. Se l’errore è sufficientemente catastrofico, imparare la lezione sarà futile.
Ernst Malmsten, il co-fondatore di Boo.com, un noto fallimento dell’epoca della bolla delle start-up tecnologiche, ha raggiunto la conclusione che in molti casi non conta ciò che si fa, ma se lo si faccia gradualmente o di carriera. Boo.com vendeva abiti e accessori, ma il modo del suo fallimento sembra preannunciare quello della Northern Rock [una banca inglese, NdRufus]: la causa immediata della sua implosione fu l’improvviso rifiuto dei finanziatori di sostenere il suo modello d’affari aggressivo. Non c’era tournée di prova off Broadway: Boo si era lanciato su grande scala con un sito 3D molto costoso che era molto in anticipo su ciò che i navigatori e le centrali di vendita telefonica erano pronti a vedere. Errori limitati nel design del sito furono ingigantiti dalla scala ambiziosa del lancio. Malmsten dice che ha imparato a fare le cose con lentezza.
Gli intervistati di questa pagina hanno in comune hanno una cosa in comune: i loro tormenti sono diventati impossibili da ignorare. Ernst Malmsten ha visto i finanziatori staccare la spina improvvisamente; la gaffe di Ratner gli è stata scagliata all’indietro dai giornali; Lucy Prebble ha dovuto leggere il necrologio della sua opera teatrale sul New York Times, «artificiale, tutto fumo (o fumo e fiato) e poco arrosto» e lo spettacolo venne ritirato poco dopo. Twyla Tharp, anch’essa, non poteva certo ignorare il messaggio dei critici.
Naturalmente, una persona che veementemente nega di avere fallito difficilmente potrà accettare una intervista sull’argomento di quel fallimento. Ci sono eccezioni: pensate al pranzo col Financial Times di Donald Rumsfeld, nel quale con molto brio giustificò la pasticciata invasione dell’Iraq, liquidò le mai trovate armi di distruzione di massa come oggetti del passato e fece spallucce ala critiche del suo stile di direzione («non gli do molto credito»).
Nel mio studio dei fallimenti, Rumsfeld è un personaggio affascinante. Il suo rifiuto a ascoltare gli avvertimenti dei suoi stessi generali – ben documentati nei racconti della guerra in Iraq come The Gamble e The Fourth Star – è impressionante. In una conferenza stampa tristemente nota, più o meno nel momento di massima dell’insorgenza in Iraq, egli prese l’iniziativa di stampo orwelliano di proibire al suo generale di maggior rango, Peter Pace, di usare la parola «insorti».
. . .
E tuttavia la capacità di negazione di Rumsfeld non è terribilmente insolita. Gli psicologi sociali Carl Tavris e Elliot Aronson, autori di Mistakes were made (but not by me), spiegano che siamo facilmente attirati dentro un ciclo di autogiustificazione. Una volta che un investigatore si è convinto della colpevolezza di un indiziato, o un manager ha scelto una nuova audace direzione strategica, ogni prova in senso opposto è altamente scoraggiante e sarà spesso rifiutata senza esitazioni. Questa dissonanza cognitiva può essere estremamente potente, e alcuni dei conseguenti errori della giustizia descritti da Tavris e Aronson sfidano l’incredulità. Quando fu introdotto il test del DNA, numerosi pubblici ministeri si ritrovarono davanti le prove inconfutabili che lo sperma trovato sul cadavere di, diciamo, una vittima di stupro e omicidio non concordava col DNA dell’uomo che avevano messo in prigione. In alcuni casi i pubblici ministeri si spinsero a avanzare spiegazioni che comportavano contorsionismi straordinari per giustificare come potesse essersi verificato questo stato di affari – piuttosto che accettare la conclusione dolorosa ma dotata di evidenza schiacciante che avevano commesso un errore.
Tavris e Aronson reinterpretano anche il noto esperimento sull’obbedienza di Stanley Milgram, nel quale i soggetti dello studio si mostravano spesso disposti a somministrare scariche elettriche apparentemente fatali. L’esperimento è abitualmente spiegato nel senso che mostra che alcune persone faranno qualunque cosa se una figura rivestita di autorità glielo dice. Ma c’è di mezzo qualcos’altro: le scariche erano gradualmente aumentate di intensità dal trascurabile al pericoloso. Non c’era un punto ovvio nel quale il soggetto dell’esperimento potesse trovare una ragione per rifiutarsi di continuare, perché ogni scarica era simile alla precedente. Tavris e Aronson segnalano che il momento di lasciare è anche il momento di ammettere che le scariche precedenti erano state un errore. È molto difficile ammettere con noi stessi un errore simile – preferiremmo ripeterlo, in un atto di autogiustificazione.
I rituali quotidiani della vita sono accuratamente costruiti per far sì che le persone sperimentino la dolorosa consapevolezza del fallimento il più raramente possibile. Pensate a quella onorata tradizione della vita in ufficio, i panino dei complimenti. Il panino dei complimenti è una critica resa tollerabile perché contenuta all’interno di due deliziose fette di lode: «Penso che sia un lavoro davvero buono e inventivo. Sarebbe meraviglioso se tu potessi [inserire la critica]. Ma nel complesso, come dicevoè è molto buono» .
Il panino dei complimenti funziona a causa di quello che l’economista comportamentale Richard Thaler chiama “la redazione edonistica”. Poiché le perdite sono di gran lunga più dolorose dei guadagni vale la pena di comporre una perdita all’interno di un guadagno più vasto: se ricevo un rimborso di tasse per 150 sterline ma ne perdo 10 per strada, la redazione edonistica mi fa ragionare che in realtà ho guadagnato 140 sterline. Il panino dei complimenti utilizza lo stesso principio: permette alle persone di salvare la faccia. Tuttavia come strumento di verifica è rischioso: il contenuto critico avvolto nelle lodi alla fine può andare perduto. Se dite: «È eccellente, ma dovresti sistemare…», io capisco: «È ampiamente soddisfacente». Io mi sento meglio, ma non migliorerò. Così non può andare bene, ma qual è la soluzione?
Ci sono persone che senza battere ciglio sembrano avere l’abilità di analizzare i loro errori e imparare da essi. La maggior parte di noi non ricade in quella categoria, invece. Il generale David Petraeus, celebrato per i suoi successi in Irak, era noto come giovane ufficiale per la sua incapacità di ammettere anche solo lontanamente di essere nel torto: era il rovescio della medaglia di un brillante, infaticabile perfezionismo. Ma nel 1982, uno dei primi comandanti del giovane Petraeus, il Maggior Generale Jack Galvin, sistemò Petraeus nel ruolo di critico ufficiale. «Il mio lavoro è guidare la divisione, e il tuo lavoro è criticarmi», sostenne Galvin per sopraffare le esitazioni di Petraeus. Galvin capiva bene che non solo non ci su può permettere di ignorare le critiche, ma dobbiamo anche fare lo sforzo di sollecitarle.
L’esperienza di Gerald Ratner, a questo proposito, è rivelatrice. Prima di pronunciare il suo fatale discorso all’associazione dei dirigenti d’azienda, si consultò con l’esperta di pubbliche relazioni Lynne Franks e gli spiegò che che aveva intenzione di utilizzare le battutacce che avevano riscosso un certo successo nel giro delle conferenze da dopocena, compresa la frase sulla “spazzatura”. Franks gli disse di fare invece un discorso sull’etica negli affari. Lui la ignorò. Ignorò anche il consiglio di sua moglie e perfino quello della donna addetta al gobbo.
Un esempio da manuale dell’ignorare dei buoni consigli? Sfortunatamente la cose non sono così ben definite. Ratner chiese al responsabile della ragioneria dell’azienda, un fidato colalboratore, che gli disse di utilizzare battute anche più audaci. Ratner ricorda che il suo amico Michael Green, della Carlton Communications, pensava che il discorso fosse andato bene; così pure Charles Saatchi (tutte le critiche femminili erano nel giusto; tutti gli uomini nel torto. Non è chiaro se questo è uno schema affidabile. Forse). In breve, si possono anche ricevere buoni consigli, ma rimane il problema di decide quali consigli usare.
Il fallimento non ci lascia. L’economista Paul Ormerod fa notare (in un libro chiamato Why most things fail, naturalmente) che ogni anno scompare il dieci per cento delle aziende americane. Il fallimento ha il dono dell’ubiquità, il che fa pensare che essere capaci di gestire il fallimento sia una abilità importante. Probabilmente on siamo molto bravi in questo campo. Una delle prime scoperte nel campo ora caldissimo dell’economia comportamentale è stata l’esistenza della avversione alla perdita – cioè il fatto che sembra che ci si preoccupi più di perdere ciò che si ha che di guadagnare qualcosa di nuovo. Ricerche più recenti sui mercati azionari, il poker professionistico e perfino i grande successo televisivo di Deal or no deal [il nome internazionale del format televisivo noto in Italia come Affari tuoi, NdRufus] suggeriscono che reagiamo male alla prospettiva di subire delle perdite, prendendo rischi eccessivi nel tentativo di riguadagnare ciò che dovremmo considerare come ormai andato.
Quando Ernst Malmsten dice che non ha mai considerato che il fallimento fosse possibile, questo non è il modo col quale ragiona la maggior parte delle persone. La persona tipica – almeno negli esperimenti da laboratorio degli psicologi e degli economisti – è troppo conservatrice, troppo spaventata dal fallimento. Malmsten, tuttavia, è un imprenditore seriale; dopo aver perso 130 milioni di denartod egli investitori, ora dice: «Ho più paura del fallimento, adesso». Dovrebbe averne.
Lucy Prebble è forse nella posizione più strana dei nostri tre sopravvissuti: ha scritto un testo teatrale e ha ricevuto due reazioni completamente differenti sui due lati opposti dell’Atlantico. Non ci si può meravigliare che si senta «separata» dal successo inglese dell’opera. È un promemoria che il successo e il fallimento sono talvolta separati da casualità davvero minime.
E tuttavia, l’impressione che faranno sarà sempre molto diversa. Come ci ricordano certi cartelli motivazionali, Rudyard Kipling ci invitava a «affrontare trionfo e disastro e trattare questi due impostori allo stesso modo». È un pensiero improbabile. Alcune persone possono prosperare dopo un disastro; altri semplicemente si trascinano verso qualunque cosa possa arrivare dopo. Ma rattare trionfo e disastro allo stesso modo? Assomiglia in modo sospetto a Donald Rumsfeld.
………………………………………….
Lucy Prebble
Autrice di Enron – successo nel West End e fiasco a Broadway
A ventotto anni, la sceneggiatrice Lucy Prebble divenne la beniamina dei critici teatrali inglesi per avere realizzato l’impensabile – trarre un’opera teatrale dalla contabilità. Enron, il suo musical, che racconta l’ascesa e la caduta della compagnia petrolifera texana, fu un successo da tutto esaurito nella stagione londinese del 2009/2010. Broadway chiamava, e lo spettacolo debuttò al Braodhurst di New York ad aprile 2010.
Poi vennero le recensioni – o piuttosto, una in particolare. Ben Brantley, il critico teatrale del New York Times, che esercita grande influenza su Broadway, condannò Enron come una: «pacchiana… affaticata lezione di economia». A maggio 2010, un mese dopo l’esordio, il sipario calò definitivamente.
Prebble aveva i suoi timori che l’opera potesse avere cattiva accoglienza critica in America. «Veniva dopo un lungo periodo di prove nelle quali avevamo la sensazione che ci fosse qualcosa che non andava». C’erano alcune «ottime recensioni», fa notare, ma non «nei giornali che contavano». TUttavia, era l’immagine nella sua mente della sua famiglia che leggeva quelle recensioni che fece piangere Prebble. «Sapere l’ansia e il disappunto che avrebbero provato per me… mi ha turbato molto».
Le critiche fecero male «sia più che meno» di quanto si aspettasse: «Di meno», dice, «perché è un’ impresa di gruppo, e ci si accorge molto più dell’innata gentilezza e educazione delle persone quando si sostengono le une le altre nei fallimenti». Ma fu più doloroso perché si sentiva male per il cast e per le maestranze, che si ritrovarono inaspettatamente disoccupati. Prebble si sentiva in colpa, e anche responsabile – per aver fatto fare una brutta figura alle persone.
Prebble accolse alcune delle critiche: «C’erano alcune cose citate a proposito della scrittura che avevo sempre tacitamente pensato in disparte, ma per la maggior parte non le ho riconosciute come relative allo spettacolo che avevamo fatto; alcune sembravano come se fossero riferite a qualcos’altro». Considera le critiche e il fallimento come animali lievemente differenti. «Il fallimento è più facile da discutere e più interessante, perché l’ostacolo è interessante. Il fallimento serve come uno strumento molto potente, narrativamente». Ma, come fa notare, l’attore che felicemente racconta di passati disastri sul palcoscenico lo fa dalla posizione di chi si è lasciato quei tempi alle spalle. «A tutti piace di più quando qualcuno fallisce ma poi alla fine ha successo». Trova invece le critiche più difficili da discutere «perché sono specifiche e personali, e lo spirito con le quali sono avanzate varia così tanto. Come scrittori, siamo per natura troppo sensibili, troppo centrati su noi stessi. Io provo a prendere quel che posso dalle critiche e lasciare il resto».
Il fallimento di Prebble in America ha cambiato il modo col quale considerava il suo successo nel Regno Unito? «Mi sento più grata per quello e anche, tristemente, più distaccata». Ma la usa esperienza newyorchese non ha influenzato il modo col quale considera la sua opera: «C’erano pezzi della mia scrittura che mi facevano rabbrividire e pezzi dei quali ero orgogliosa. Ho sempre pensato che la produzione fosse fantastica». Inaspettatamente, l’ha aiutata a identificarsi con Jeffrey Skilling, l’ex amministratore della Enron, che sta scontando ventiquattro anni di carcere per frode. «Dietro alcune critiche c’era l’idea che come poteva questa ragazza inglese pensare di conoscere qualcosa di una impresa internazionale, di avidità, affari, America, di quest’uomo che ha fatto perdere alla gente attorno a lui milioni di dollari e ha visto tutto il suo mondo crollare in poche settimane? E il risultato di queste critiche è stato che ho imparato la verità della storia che provavo a raccontare».
………………………………………….
Gerald Ratner
Conferenziere ed ex gioielliere
Gerald Ratner trasformò l’impresa di famiglia in difficoltà nella più grande catena di gioiellerie del mondo, con 2500 negozi. Poi, sette anni dopo avere preso la direzione di Ratner’s, la distrusse. Con solo due battute. In un discorso che pronunciò nel 1991 all’associazione dei dirigenti di azienda, l’uomo dei quartieri settentrionali di Londra ironizzò sui suoi prodotti come «spazzatura totale», e si vantò che alcuni degli orecchini di Ratner’s «costavano meno di un tramezzino ai gamberi» [e duravano meno, NdRufus].
Il discorso dilagò attraverso i giornali popolari e eliminò una parte del valore di mercato della società valutata a 500 milioni di sterline. Ratner lasciò la società l’anno seguente e il suo nome fu tolto dal marchio nel 1994. Due decadi dopo la più grande gaffe aziendale della storia, fare un Ratner e stabilmente parte del linguaggio popolare.
Mentre pronunciava il duo discorso, Ratner non aveva idea dell’effetto che avrebbe avuto. «Quando lessi THe Sun e The Mirror il giorno seguente, capii che era una notizia», dice, «ma [pensai] che si sarebbe sgonfiata. Il primo rapporto sulle vendite che ricevetti dopo il discorso aveva un calo del 4%, ma avevo buona fiducia che si sarebbe invertito». Se solo. Invece accadde il contrario. Quando Ratner capì l’estensione del problema «fui assalito dalla nausea».
Oggi Ratner sostiene che: «è stata una cosa stupida da parte mia dirlo, ma la reazione è stata assolutamente spropositata». Il contesto è tutto, dice – dando la colpa alla recessione che la Gran Bretagna stava attraversando in quel momento. «La stampa stava cercando capri espiatori, come coi banchieri oggi. Ed eccomi – per come lo vedevano, un multimilionario che si prendeva gioco dei suoi clienti che stentavano a sbarcare il lunario».
La spettacolare caduta dall’empireo di Ratner fece scattare quelli che chiama i suoi «sette anni selvaggi». Gli amici gli offrirono aiuto, ma «io ero depresso», dice. Sperava di reinventarsi, ma «l’elefante nella stanza» allontanava le persone: nessuno riusciva a pensare ai suoi successi, solo a quell’unica gaffe. Uno psichiatra gli prescrisse antidepressivi, «che fecero sparire la tristezza ma mi resero più introverso. Non parlavo – nelle riunioni tacevo». Rinunciò alla pastiglie in favore del ciclismo e questo si rivelò la sua salvezza – lo rendeva «euforico». Oggi fa in bicicletta venticinque miglia al giorno.
È stato solo dopo aver fondato una catena di palestre, che ha venduto per 3,8 milioni di sterline nel 2001, che Ratner si è sentito capace di affrontare i suoi demoni e perfino di scherzare sul crollo della sua azienda di famiglia. Continua a sostenere che non ha imparato niente dal fallimento. «Al contrario. Ho imparato dal successo – quando avevo successo, scoprivo nuove opportunità e sfide, guadagnavo fiducia. Col fallimento, perdi la fiducia in te stesso».
Nonostante questo, è grato di alcune cose – l’andare in bicicletta e una nuova carriera in discorsi a pagamento per i dopo cena. «I discorsi sono terapeutici. È meglio parlare di quell’episodio. Le persone sono di solito comprensive. Credo che temano che io stia per sentirmi a disagio ma io le rallegro – entra in sintonia con altri, fa loro pensare che c’è luce alla fgine del tunnel».
Il fallimento gli ha insegnato anche ad apprezzare la sua nuova azienda, la gioielleria Gerald Online. «Sono più grato per il mio successo, questa seconda volta». In precedenza, il suo atteggiamento nei confronti del denaro era «patetico», dice. «Se il mio posto era troppo indietro in prima classe, non era abbastanza buono». Adesso è una persona più paziente, tuttavia è un misero contraccambio. «Le persone mi chiedono se sono contento di aver detto quel che ho detto. Sono ridicoli. Come potrei essere grato? Ho perso tutto».
………………………………………….
Ernst Malmsten
Co-fondatore di Boo.com
Nel 2000, Ernst Malmsten fece un disperato appello per del denaro. «Se non riusciamo a raccogliere venti milioni di dollari entro mezzanotte, Boo.com è morto». Lo svedese, co-fondatore di del venditore online di articoli di moda non riuscì a trovare quei fondi. Il giorno dopo, 18 maggio 2000, meno di una nno dopo il suo lancio, Boo.com crollò. Il sito, un tempo simbolo del boom delle aziende digitali, divenne il simbolo dei suoi eccessi, avendo bruciato centotrenta milioni di investimenti.
«Non negavamo la realtà del fatto che stesse crollando», ricorda Malmsten, «è per questo che stavamo raccogliendo fondi. Ma quando crollò fu uno shock, come una morte improvvisa». Si sentì vuoto. «Non mi sono mai sentito sollevato per il fatto che fosse finita. Conosco delle persone che si sono sentite liberate [quando la loro azienda è fallita]. Io no. Mi sentii svuotato. Amavo quell’azienda e ne ero così orgoglioso. Pensavamo di essere inarrestabili». Ammette, ora, che questo può essere prova dell’ingenuità del consiglio d’amministrazione.
Nonostante questo, c’era consolazione da trovare nel fatto che la sparizione di Boo.com era parte di un fenomeno mondiale, lo scoppio della bolla delle aziende digitali – perché questo voelva dire che il fallimento non era percepito in modo tanto personale. E la pubblicità che la sparizione dell’azienda attirò fu un vantaggio, dice Mamsten. «A causa del fatto che eravamo tanto sotto l’occhio dei riflettori è stato più facile. Il nostro fallimento è stato molto pubblico, così amici e familiari sapevano di doversi raccogliere attorno a noi. Se fosse stato un fallimento privato e fossimo stati isolati, non avremmo ricevuto tanto sostegno personale».
Malmsten dà il merito della sua resilienza alla sua educazione. «Non ho mai sentito che ci si aspettasse da me che avessi successo», dice. «Sapere che la mia famiglia mi avrebbe sempre sostenuto mi ha aiutato – sapevo che ci sarebbe sempre stato un posto dove andare dove mi sarei sentito al sicuro». Malmsten crede che questa rete di sicurezza l’abbia protetto dalla depressione, e dice che «pensa di avere fatto fronte bene». Dopo lo shock, dice, ha analizzato quel che non aveva funzionato e poi è «andato avanti». Sebbene non accetti le critiche gli sono state rivolte a quel tempo («Non avremmo mai potuto essere pari alle aspettative eccessive»), riconosce che non può minimizzare il fallimento («In fin dei conti, abbiamo provato a costruire un impero e tutto si è dissolto»).
Malmsten aveva temuto che il fallimento della notorietà della sua azienda avrebbe tenuto le persone alla larga da lui. Invece, dice, «non allontana le persone. Loro pensano che sia affascinante che un giovane sia al centro di un fenomeno del mondo degli affari». Sostiene anche di non avere avuto scarsità di offerte di lavoro. Oggi, come principale responsabile operativo di Lara Bohinc, lo stilista di accessori di base nel Regno Unito nel quale ha una quota del 40%, dice di essere più cauto. «Boo.com mi ha reso più avverso al rischio… Eravamo giovani e non pensavamo che iol fallimento fosse una possibilità. Temo di più il fallimento, ora, perché so che le aziende possono fallire, mentre prima non credo che lo sapessi». In effetti Malmsten ammette di essere stato riluttante ad avventurarsi nell’e-commerce di nuovo. «Siamo stati lenti ad aprire un sito a Lara Bohinc. Avremmo potuto farlo prima ma volevo prendere tempo… abbiamo [fatto] molto beta testing».
Da europeo, dice, si sente più a suo agio nel discutere il fallimento che il successo, perché «in Inghilterra e Scandinavia siamo più umili [che in America]». Le persone appartenenti alle culture europee, dice, sono più oneste e analitiche riguardo al fallimento che al successo. «Avete davvero intenzione di [confessare che il vostro successo] è dovuto al fatto che avete fregato qualcuno?».