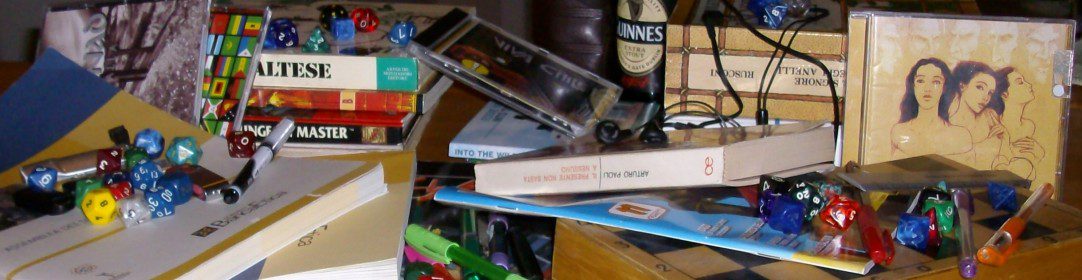Culture aziendali
Il mio amico e compagno in Banca Etica Paolo Mascellani mi ha suggerito la lettura del documento sulla propria cultura aziendale che Netflix ha reso pubblico in rete.
Paolo sa che i temi della cultura e della organizzazione aziendale mi interessano molto, ma probabilmente mi ha segnalato la lettura per una questione più attinente alla nostra militanza comune, diciamo di tipo etico. Il documento, infatti, alla fin fine parla di questo: è parte dichiarazione di intenti e manifesto politico, parte codice di comportamento per gli impiegati, parte chiarimento dei termini per eventuali assunzioni (se vieni da noi, questo è quel che troverai…). Ma soprattutto è un documento che parla frequentemente di valori e quindi, appunto, parla di etica e di identità aziendale. Lo fa anche con un salutare scetticismo, a partire dall’osservazione che la Enron aveva una lapide nella hall della propria sede che dichiarava i suoi valori (integrità, comunicazione, rispetto, eccellenza): poi sono andati tutti in galera, a dimostrazione che non basta dichiarare di avere dei valori per essere etici, una notazione che molte organizzazioni del Terzo Settore o a movente ideale e molti partiti politici – per non parlare della Chiesa – dovrebbero sempre tenere presente.
Sotto questo punto di vista Netflix sceglie una via alternativa che ho trovato pragmaticamente interessante: i valori sono quelli che sono dimostrati nella scelta di coloro che vengono assunti, ricompensati, promossi o licenziati (a pag. 6).
Naturalmente vale la notazione che parlando di etica, in questo caso, si tratta di un’etica di tipo individuale e non universale: il documento cioè illustra il codice di valori di Netflix, non quello dell’umanità – e quindi si possono non condividere i suoi valori, ma non negare il fatto che, come organizzazione, si è data una propria identità che è parecchio di più di un semplice codice di condotta. Questo va tenuto presente, per esempio, quando vengono descritte le pratiche di gestione e remunerazione del personale, una parte che io ho trovato interessantissima ma che probabilmente farebbe inarcare più di un sopracciglio a un sindacalista di stampo europeo (e ogni tanto anche a me).
Ma è nella sua interezza che si tratta di una lettura molto interessante e, scusandomi per il fatto che non posso tradurla, la consiglio caldamente. Il documento, infatti, merita di essere letto anche al di là delle riflessioni etiche che si possono fare: per esempio è un altro esempio (l’ennesimo, direi) di conduzione di una azienda importante e di successo sulla base di meccaniche (larvatamente) cooperative; presenta con forza le motivazioni del perché è più importante avere contesti sicuri che regole sicure (un concetto che chi è abituato ai training non faticherà a riconoscere); ha un pezzetto da manuale sulle crisi di crescita e la gestione della complessità organizzativa (da pag. 42 alla 58); e infine presenta ogni tanto osservazioni en passant che spalancano altri campi di riflessione, come il fatto che Netflix si considera prima di tutto un’azienda di tipo creativo, invece che, boh, commerciale. Ed è evidente che a Netflix a questo codice ci tengono tantissimo: si premurano perfino di ricordare che l’attuale è l’aggiornamento di una prima versione del 2009.
Sulla base di questa lettura, della quale sono grato a Paolo, ho un po’ approfondito l’argomento, andando a cercare sulla rete la possibile esistenza di altre dichiarazioni o descrizioni di cultura aziendale e facendo un paio di scoperte che vi racconto.
Intanto, dichiarazioni di intenti di questo livello non sono del tutto comuni. Anche aziende con una fortissima e riconoscibile identità aziendale non pubblicano documenti del genere. Facebook, per esempio, è prodigo di interviste ma sul proprio sito limita la descrizione della propria cultura a poche righe:
Facebook è definito dalla nostra cultura da hacker – un ambiente che ricompensa le soluzioni creative ai problemi e la capacità di prendere rapidamente decisioni. Noi incoraggiamo le persone a essere audaci. La nostra cultura aperta fa sì che ognuno sia informato e permette alle persone di muoversi liberamente e risolvere i problemi che più gli interessano. Lavoriamo in piccoli gruppi e ci muoviamo velocemente per sviluppare nuovi prodotti, in un costante processo di iterazione e miglioramento. La frase «questo viaggio è terminato all’1%» è scritta sulle nostre pareti, per ricordarci che abbiamo appena iniziato a completare la nostra missione di rendere il mondo più aperto e più connesso.
Si capisce abbastanza quel che vogliono dire (e fare) se si confronta questo testo, per esempio, con un articolo di FastCompany del 2015 che racconta come Facebook tenti di scalare le proprie dinamiche interne in maniera da mantenere quell’aria da piccola start up inventiva ed esplosiva di dieci anni fa, ma dal punto di vista etico è un po’ povero:
Facebook incoraggia i propri lavoratori a essere audaci ed aperti, a vivere la sfida e fare la differenza
che sembra esattamente quel tipo di gergo contro il quale si scaglia periodicamente il sarcasmo della serie Silicon Valley, anche se questa insistenza sul “fare la differenza” è piuttosto interessante non solo come impostazione etica ma anche come agente di meccaniche interne: leggenda vuole che quando ti assumono ti invitino ad andare liberamente nel gruppo di sviluppatori dove pensi di fare la maggiore differenza per cambiare il mondo: non è solo un gran modo per motivarti, mi pare anche un ottimo metodo per metterti alla prova e decidere se licenziarti alla fine del periodo di prova, a seconda di dove sei andato.
Mi pare.
Comunque, tornando a noi, dicevo che documenti complessi come quelli di Netflix non sono la regola. Zappos, che pure si sa che ha a cuore la cultura organizzativa, si limita a una scarna paginetta. Amazon, che pure ha una sezione del proprio sito dedicata a se stessa piuttosto ampia, sceglie un approccio totalmente narrativo, presentando storie di successo dei propri dipendenti (lo stesso fa sostanzialmente Apple).
E questo è un tipo di riduzione della interpretazione del concetto di cultura aziendale che mi sembra comune: un modo, cioè, per descrivere ai propri (futuri?) dipendenti cosa ci si aspetta da loro e cosa devono fare. Non a caso la Southwest, che viene sempre citata in maniera estremamente positiva in tutti gli articoli e gli studi sul benessere e la cultura organizzativa, mette la pagina sulla propria cultura nella parte del proprio sito dedicata alle opportunità di lavoro (ancora, con un approccio narrativo, compresa la storia dell’impiegato modello del mese); in realtà lo fa anche Netflix (ma poi fa girare le slide anche altrove).
Però non si tratta solo di questo: anche chi ha documenti più ampi, sembra preoccupato di dimostrare che grande ambiente di lavoro sia il proprio. È molto evidente in LinkedIn, per esempio
il che spiega anche perché sia così frequente il riferimento, in tutte le aziende, al voler essere una famiglia, al divertirsi e mantenere un senso dell’humor, a collaborare, a essere aperti (oltre che, naturalmente, audaci, coraggiosi, inventivi, cambiare il mondo eccetera). Nel documento di LinkedIn si vede bene: se trasformi te stesso, migliorandoti professionalmente in un ambiente eccezionale, allora trasformi anche l’azienda, favorendone il progresso e la crescita, e allora l’azienda, compiendo la propria mission, trasformerà il mondo, secondo i migliori canoni della Silicon Valley. C’è un articolo in italiano, di una dipendente di HootSuite, molto indicativo in questo senso: la nostra cultura aziendale è essere amichevoli.
Il problema è che, apparentemente, questo tipo di impostazione è insufficiente. Ho trovato un breve articolo interessante sulla Harvard Business Review
Nella nostra esperienza, troppe aziende pensano alla cultura come a un modo per far sentir bene le persone sul luogo di lavoro e come un modo per aiutare i dipendenti – e quindi l’organizzazione – a rendere al meglio. Le società ad alto rendimento pensano alla cultura in maniera differente. Sanno che le culture vincenti non riguardano solo il senso di appartenenza: esse riguardano anche, senza falsi imbarazzi, i risultati.
Con più precisione, un altro articolo della stessa rivista argomenta:
Ma questo non è davvero ciò che la cultura riguarda, e non è nemmeno un modo utile di considerare le organizzazioni. Perché? Perché la cultura non riguarda solo l’unione; riguarda anche la divisione. Piuttosto che una “cosa” deterministica che plasma i comportamenti e unisce le persone, la cultura è qualcosa che le persone usano, spesso strategicamente, per raggiungere obiettivi. Può anche fornire la base sulla quale le persone contestano e oppongono certe idee e valori, mentre accettano altri valori associati a un particolare contesto culturale. […] Fondamentalmente, una cultura non è un insieme di valori (marginalmente) condivisi; è una ragnatela di relazioni di potere nella quale le persone sono immischiate e che usano per raggiungere fini sia personali che collettivi ma che può anche restringere la loro abilità di raggiungere gli obiettivi. Queste relazioni di potere possono funzionare per unire le persone, ma possono anche allontanarle perché sono il prodotto di differenti accessi alle risorse. E le differenze nel potere influenzano il modo con il quale rispondiamo e ragioniamo circa i valori dichiarati come condivisi dai componenti del gruppo.
Incidentalmente: queste ultime righe sono fondamentali per chiunque lavori o voglia impegnarsi in una organizzazione a movente ideale – o in un gruppo politico volto al cambiamento – e vanno meditate a lungo se non si vuol finire, come amici più sanguigni di me dicono, a far la vergine in casino. Ma tornado all’analisi dei diversi documenti, la differenza mi sembra evidente: in Netflix il ragionamento sul potere – chi teniamo e chi mandiamo via – è evidente. In LinkedIn? Non tanto.
Del resto è evidente nella dichiarazione di cultura aziendale di HubSpot (un altro documento notevole e con molti punti in comune con quello di Netflix): quando parlano della trasparenza, si sentono in dovere di dichiarare che la trasparenza non equivale alla democrazia: la trasparenza riguarda l’essere aperti, non il decidere per consenso. Tutti abbiamo diritto di parola, ma non tutti hanno diritto di voto (pag. 45). A Facebook come in Hubspot tutti lavorano in grandi open space senza distinzioni di rango, compresi Zuckerberg o Sheryl Sandberg: ma non tutti sono uguali, ovviamente, e Zuckerberg sarà sempre il capo (casomai, la forza di Zuckerberg starà nel capire quando fidarsi del parere dei suoi collaboratori e non far valere la sua posizione gerarchica).
Proprio il caso di HubSpot, peraltro, invita alla cautela nell’esame di questi documenti: l’azienda ha vinto dei premi per il clima lavorativo, ma nel 2015 è rimasta anche impigliata in una sgradevole controversia con un ex impiegato (è quel Lyons del cui libro ho segnalato a suo tempo la recensione su Internazionale) che ha portato anche al licenziamento di un dirigente. Qui parliamo di efficacia e chiarezza della visione aziendale, meno della capacità di vivere al cento per cento i valori professati.
Tornando all’articolo della Harvard Business Review, vi si sostiene che le organizzazioni la cui cultura aziendale è efficace devono promuovere e coltivare certi valori, quali onestà e integrità, orientamento alla prestazione e al risultato, accontabilità e senso di responsabilità, apertura alla collaborazione, agilità a e adattabilità, innovatività e senso di intraprendenza e, infine, ambizione al successo.
Il che è un po’ la scoperta dell’acqua calda e, dal punto di vista di chi volesse aprire oggi la propria start up, diciamo, un po’ confonde: tutte le aziende più importanti hanno un qualche codice di condotta di questo genere (uno dei più interessanti è IDEO, che ha una serie di video, uno per ciascun valore: brevi ed efficaci. Vedendoli ho pensato alle molte pagine, peraltro belle, del Codice Etico di Banca Etica, e a quelle, anch’esse molte, del nostro Manifesto Politico, e ho avuto un trasalimento). Il punto non è considerare augurabili questi valori in senso generico, ma il preciso mix con i quali li si combina in maniera pratica nella propria organizzazione, privilegiandone alcuni e curandone meno altri. Il che richiede un pensiero strategico, che è esattamente ciò che raccomanda Google (a Google badano al sodo: la loro pagina su se stessi è bellissima, ma non c’è una dichiarazione di intenti complessiva che sia una):
e naturalmente la capacità di ragionare in senso strategico e di costruire una visione aziendale appropriata alle condizioni del mercato e di successo non è da tutti, e non può essere insegnata oltre un certo tanto. Se volete curiosare e copiare da altre aziende c’è in rete una pletora di articoli, in molti dei quali alcuni nomi tornano frequentemente. Io li trovo talvolta irritanti e, spesso, banalmente pubblicitari, ma si capisce molto di come ogni azienda è organizzata e quindi li metto comunque qui sotto, come punti di partenza per altre letture:
- un articolo su Ninja Marketing, con uno studio di caso di una azienda americana (in italiano);
- un articolo recente su Emplify che discute in vario modo (piuttosto interessante) come costruire la propria cultura aziendale;
- un altro articolo del 2017 su Referral Candy con venticinque aziende con grandi culture (uno di quelli che preferisco: le culture si costruiscono, non si comprano);
- uno scarno articolo del 2016 su Staples su ciò che si può imparare da cinque aziende per costruire la propria cultura aziendale;
- un articolo del 2015 su Entrepreneur, che discute dieci aziende con culture fantastiche;
- un articolo su Indeed, ciò che si può imparare da tre aziende con grandi culture;
- un articolo su Fortune, che discute l’efficacia delle dichiarazioni di intenti (mission e slogan di riferimento) di sette aziende.